In questo articolo è riportato un testo estratto dal capitolo 1 del saggio “Umanamente insostenibile. Il capitalismo nuoce gravemente ai sapiens”, che pone l’accento sul delicato equilibrio tra le radici evolutive dell’umanità e le sollecitazioni della vita contemporanea. Attraverso una serie di domande cruciali, si indagano le compatibilità e le frizioni tra il nostro patrimonio biologico e le pressioni socio-culturali, offrendo una riflessione critica sulle conseguenze del capitalismo tardo-moderno per i sapiens.

Testo estratto
“Se è vero che l’architettura della mente dei sapiens è in sostanza forgiata nell’età paleolitica, sarebbe il caso di osservare cosa dei nostri più comuni e attuali stili di vita, specialmente alla luce delle più recenti accelerazioni tecno-sociali, corrisponde ad una vera e proprio violenza a causa della incompatibilità e immodificabilità strutturale della dotazione di partenza. In buona sostanza, la domanda sottesa a questa nostra ricerca è la seguente: dove la storia recente dell’uomo ha potuto tirare la corda delle dotazioni di partenza potendo anche migliorare la condizione umana e dove invece le pressioni evolutive finiscono per spezzare la corda?
Tempo del sonno, tempo di lavoro, tempo per sé, tempo per le cure parentali, tempo per la socialità, abitudini alimentari, abitudini corporee, rapporto con la tecnologia, rapporto con le risorse (economiche), tipologie di organizzatori sociali, tipologie di aggregazioni umane e modalità di convivenza, tipologie di abitazione, modalità di ingresso e uscita dai cicli vitali, senso e qualità della vita sessuale (e rapporto col piacere), organizzazione della vita emotiva, investimento sulla progettualità familiare e non, investimento sulla creatività e sulle attitudini, rapporto con l’ambiente non-umano e con la bellezza.
Ogni punto di questo elenco e l’elenco nel suo complesso possiamo intenderli come repertorio originario della specie sapiens con il quale dover fare i conti in ogni epoca storica.
Quale pressione evolutiva e socio-culturale può sostenere la nostra dotazione di specie di partenza? Per esplorare nel dettaglio le capacità del nostro repertorio di partenza, occorre sottoporre ad osservazione puntuale ogni singolo aspetto di tale corredo bio-psico-morfologico.
Proviamo qui, brevemente, attraverso domande dirette, ad interrogare le nostre attuali vite di sapiens contemporanei, nel pieno dell’epoca tardo-capitalista, per indagare su come le sollecitazioni socio-culturali di questo momento storico siano compatibili o viceversa dirompenti rispetto al nostro repertorio evolutivo di partenza.
E, dunque, le principali domande sono le seguenti:
- Quante ore di sonno necessità la mente di un sapiens? E quante ne potrebbe perdere al massimo in una settimana senza doversi ammalare? E’ realmente concepibile rendere flessibile il sonno?
- Quante ore di attività-lavoro al giorno può reggere, mantenendo motivazione e efficienza, un sapiens? In relazione a quali sistemi motivazionali? Quanto può “spingere” e per quanto consecutivamente oltre un certo limite personale?
- Quanto tempo oniroide solitario improduttivo (me time ozioso) richiede la mente di un sapiens per riordinare memorie, affetti, pensieri, energie? Quanto si può consentire di erodere questa temporalità ai fini produttivi?
- Se si tratta di una famiglia con figli, quali tempi e quali cure parentali sono necessarie ai piccoli e ai meno piccoli dei sapiens per poter crescere mentalmente sani? Quali e quanti tempi e cure sono delegabili a strutture sociali intermedie e quali no?
- Quali e quanti rapporti amicali autentici preserviamo? A quali gruppi di amici o conoscenti sentiamo di fare parte? Quanto tempo dedichiamo a tale ambito della nostra esistenza? Quanto sentiamo di essere utili e apprezzati-amati dagli altri prossimi nella vita che svolgiamo?
- Quanto la nostra vita sociale è sotto l’egida della competizione e della performance e quanto sotto l’egida della collaborazione e cooperazione orizzontale?
- Quale regime alimentare seguiamo? Esso rispetta le nostre esigenze e contestualmente anche quelle del nostro ecosistema?
- Come trattiamo il nostro corpo-mente? Quanto siamo confidenti rispetto ai suoi segnali e quale dialogo intimo abbiamo con esso? Quali attività e quali tempi dedichiamo per seguire i suoi bisogni?
- Quanto tempo utilizziamo nell’uso compulsivo delle tecnologie prevalenti nella nostra epoca? Quanto riusciamo a sottrarci dalla dipendenza e dal dominio di tale temporalità tossica?
- Quale rapporto abbiamo con la nostra personale economia? Abbiamo consapevolezza del rapporto tra disponibilità e bisogni essenziali?
- Viviamo in una abitazione sufficientemente dignitosa e ospitale?
- Abbiamo consapevolezza delle eventuali tossicità delle appartenenze (famigliari o sociali)? Siamo in grado di agire su di esse preservandoci da un eccesso di esposizione a tali tossicità?
- Siamo coerenti e aderenti con i nostri bisogni evolutivi relativi ai nostri effettivi cicli vitali? Oppure sentiamo anacronisticamente di possedere un’età troppo superiore (o inferiore) a quella anagrafica? Ci sentiamo sufficientemente attivi e protagonisti della nostra vita sociale o viceversa estranei e inutili?
- Siamo sufficientemente sereni con la nostra sessualità? Viviamo la nostra sessualità con la necessaria libertà? O la sentiamo coartata o estranea a noi? Quale rapporto abbiamo con il sistema del piacere?
- Facciamo caso ai nostri sbalzi emotivi (stati ansiosi, malinconici, etc.)? Siamo in grado di riconoscere le sfumature emotive e contestualizzarle, di viverle con la necessaria espressività? Siamo in grado di distinguere tra cause esterne e ambientali e vulnerabilità personali rispetto ai nostri stati emotivi?
- Riusciamo a proiettarci nel futuro (prossimo e remoto) in termini di progetti, desideri e obiettivi?
- Riusciamo a immaginare di mettere a frutto le nostre più vere attitudini al servizio di noi stessi e degli altri? Abbiamo consapevolezza delle peculiarità delle nostre capacità espressive e delle nostre piccole e grandi vocazioni?
- Quanto tempo riusciamo a vivere immersi nel mondo non-umano (comunemente detto “natura”) e a goderne della sua bellezza? Abbiamo un privilegiato rapporto con la bellezza? Abbiamo sufficiente consapevolezza delle criticità ecologiche in corso?”
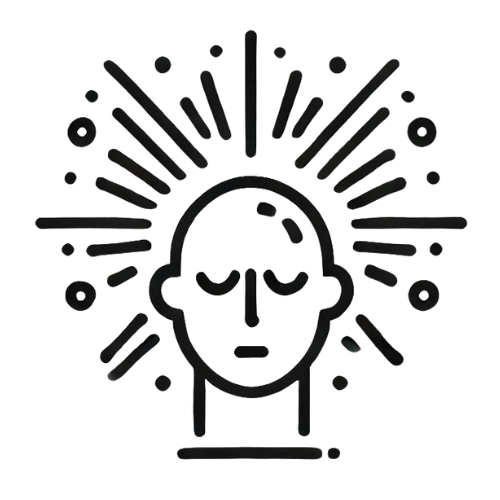

Lascia un commento