Viviamo immersi in narrazioni culturali e identitarie che non abbiamo scelto. Sono storie che ci arrivano dal passato, intrecciate a sistemi economici e modelli sociali che hanno radici lontane. Una di queste storie è il mito del self-made man, quello dell’uomo che “s’è fatto tutto da solo”. Un modello di derivazione americana, secondo il quale il successo sarebbe un merito personale e il fallimento una colpa. Ma cosa accadrebbe se ci fermassimo a chiederci: chi scrive queste storie? Se non ci fanno stare bene, perché dovremmo identificarci in esse?
Indice
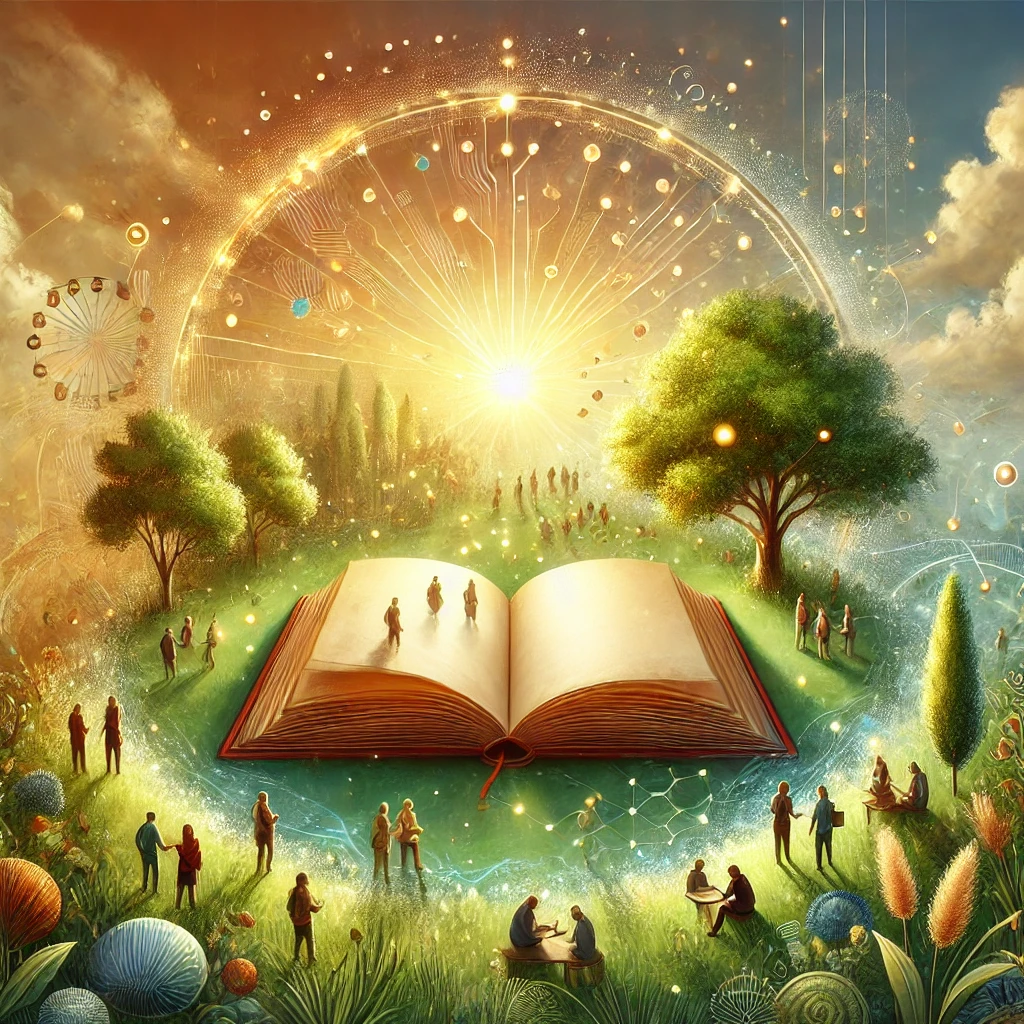
In breve: cos’è la cultura e qual è la sua funzione sociale
“La cultura consiste in modelli di comportamento, simboli e tradizioni trasmessi socialmente, che modellano le percezioni, i valori e le azioni degli individui all’interno di una comunità.”
— Clifford Geertz, Interpretazione di culture (1973).
La cultura non è un destino immutabile. È un processo, una costruzione continua. La cultura ci parla del modo in cui si concepiscono le identità individuali e collettive di una data società. In questo modo, grazie a principi e valori condivisi, diventa possibile coordinarci socialmente e riconoscerci come appartenenti ad una data comunità. Tuttavia, non tutte le culture sono sempre benefiche. Facciamo un esempio concreto, vediamo perché la cultura del self-made man non gioca a nostro favore.
Self-made man: un modello culturale disfunzionale
Senza ombra di dubbio, la cultura del self-made man, propria del capitalismo e caratterizzata da un forte “individualismo”, presenta caratteristiche che favoriscono stili di vita spesso infelici, compromettendo la salute psico-fisica. Per realizzarsi (e spesso anche solo per sopravvivere), l’essere umano “occidentalizzato” deve competere costantemente. Questa è una delle principali ragioni per le quali accumula poche ore di sonno, vive a suon di ritmi sfrenati e patisce elevate dosi di stress. O per le quali finisce con l’abusare dell’utilizzo di device, o con il mangiare male e frettolosamente, o persino con il vivere relazioni superficiali e discontinue. Per tutti questi motivi, il modello del self-made man risulta disfunzionale. Approfondiamo ora le origini dell’individualismo nel mondo del lavoro.
Individualismo e concorrenza sul lavoro: le origini
Il modello individualista-competitivo non è sempre esistito, ma è una costruzione storica le cui origini si intrecciano con il liberalismo come credo politico basato sul self government. Questo approccio, frutto di molteplici influenze culturali e filosofiche, trova una delle sue basi nel pensiero di Adam Smith. Considerato il padre dell’economia politica moderna, costui ha teorizzato il concetto di “libero mercato”.
Per Smith, l’interesse personale e la competizione tra individui rappresentano i motori fondamentali dello sviluppo economico e dell’accumulo di ricchezza nazionale. In La ricchezza delle nazioni (1776), egli sviluppò l’ipotesi seconda la quale le pulsioni personali alla possessività e al potere, avrebbero dovuto contribuire indirettamente al benessere collettivo. A tal proposito scriveva: “Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla loro considerazione del proprio interesse”.
La cooperazione nel self-made man
Parliamoci chiaro: sapiens sono animali sociali. La cooperazione fa parte del nostro repertorio di specie. Quel che cambia nella cultura del self-made man è il modo in cui si realizza, non il fatto che di per sé non ci sia. La cooperazione nel mondo del lavoro occidentalizzato, sembra più che altro arginata a necessità aziendali dove impariamo a fare “squadra” per ragioni funzionali agli obiettivi di business. Ecco dove sta il problema! Non si tratta di una forma collaborativa volta al bene comune. Tanto è vero che all’interno delle aziende si continuano a coltivare gelosie e si è spesso in competizione con i colleghi, visti in parte come membri dello stesso team e in parte come concorrenti. La logica del “fare carriera” è più o meno la seguente: “se salgo di livello io, allo stesso posto non puoi essere promosso anche tu”. Prevalere è quindi necessario per affermarsi. Ecco che l’idea di Smith tradotta nel reale si rivela essere un boomerang sul piano del benessere socio-relazionale.
Il mito dell’isolamento
Questa narrazione individualista magari può stimolare alcuni a dare effettivamente il massimo, ma non ci rende liberi. Ci isola. E l’isolamento è un terreno fertile per il malessere: aumenta l’ansia, riduce l’empatia, ci spinge a vedere gli altri come ostacoli anziché come alleati. Se però diventiamo consapevoli che il modello culturale in cui viviamo è solo uno dei tanti possibili, e mettiamo a fuoco che non ci fa stare bene, allora possiamo aprirci a nuove prospettive. La domanda a questo punto è: quali caratteristiche dovrebbero possedere le narrazioni che ci guidano, per fare in modo che da gabbie che ci limitano diventino ponti che ci connettono?
Co-creare il futuro
Come abbiamo visto, le culture sono intrecciate alle strutture di potere, agli interessi economici, ai media. Cambiare narrazione è una trasformazione profonda, che riguarda processi lunghi e complessi. Significa affrontare non solo resistenze esterne, ma anche interne: paure, abitudini, convinzioni radicate. Tuttavia, nel lungo termine è fattibile. Ecco perché la complessità del percorso non dovrebbe spaventarci: se iniziare a pesarci oggi dovesse portare beneficio ai nostri figli, nipoti o bisnipoti, ne sarà comunque valsa la pena!
Tracce di nuove narrative, più empatiche
Dovremmo iniziare a riflettere su come celebrare la collaborazione anziché la competizione. Possiamo creare spazi in cui la vulnerabilità non sia vista come una debolezza, ma come un punto di forza. Possiamo raccontare – e vivere – narrazioni che mettano al centro il benessere collettivo, la solidarietà, l’empatia. Di una analoga operazione “semantica”, parla tra l’altro anche Luigi Maiello in questo interessantissimo articolo sul Fatto Quotidiano: Una lettura socio-culturale del nuovo codice della strada: perché non funzionerà senza un cambio di narrazione.
Il reale potere sta nelle nostre mani
La buona notizia è che per iniziare ad attuare questo macro-cambiamento sociale non occorre attendere i vertici (la politica arriverà con i suoi tempi). La forza delle relazioni umane, che passa da genitore a figlio, da fratello a sorella, da amico ad amico o da vicina a vicino, quando si propaga su vasta scala è la cosa più potente che ci sia! Riflettere assieme su come un gesto gentile tra sconosciuti possa avere un potere di radicale trasformazione della società, è già rivoluzionario. Divisi come siamo dalla concezione individualista, fin troppo spesso ci dimentichiamo quanto il reale potere sia collettivo: la pioggia che nutre i terreni e la vita non è composta da uno schizzo, ma è fatta di tante gocce.
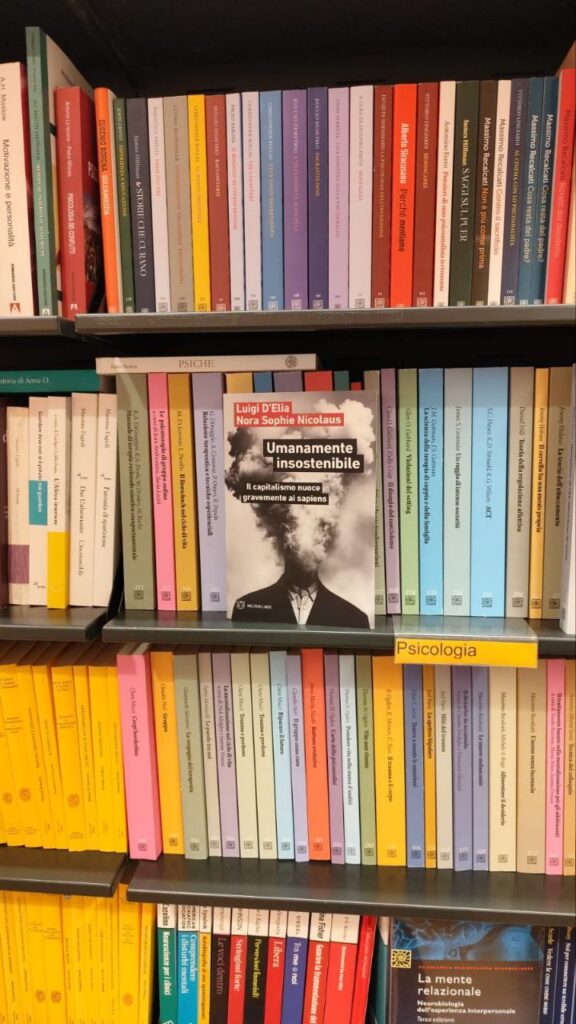
Desideri approfondire?
Clicca qui per visionare i portali dove è possibile ordinare il saggio “Umanamente insostenibile. Il capitalismo nuoce gravemente ai Sapiens”
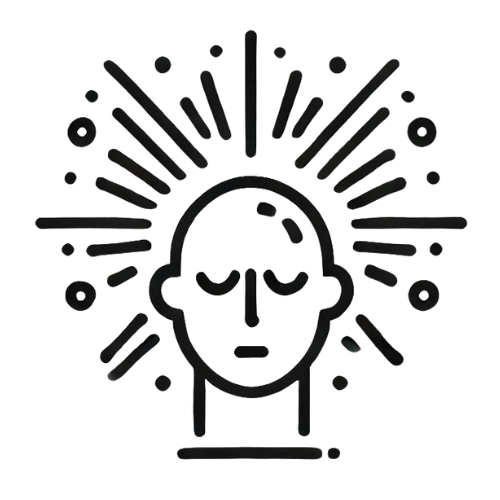

Lascia un commento